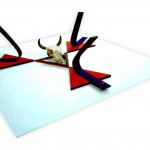BARBA O DELL’INVENZIONE DELLA TRADIZIONE
L’elemento plastico della scultura – praticata in precedenza da Calogero Barba -; i suoi pieni e i suoi vuoti, il suo occupare Io spazio, presupponendone le amplificazioni in una successione virtuale di infrastrutture potenzialmente disposte a relazionarsi con altri
fattori altrettanto plastici, differenziati tra loro ma ben articolati, simbolici e radianti nei loro significati d’insieme; tali disponibilità creative hanno consentito al lavoro di Barba di prodursi più recentemente in un ciclo di suggestivi “scenari” votati alIa rappresentazione di oggetti e di forme, di concetti postulativi che hanno arricchito l’orizzonte visivo dell’artista e l’intreccio dei suoi interessi teorico-estetici. Infatti, un proficuo recupero non soltanto mentale di una territorialità topografica, dei suoi tessuti comportamentali, delle sue tradizioni, nonché della sua peculiare “oggettistica” attinente al lavoro dei campi di una volta e alle testimonianze ricavate dal sottosuolo, di antiche civiltà, costituiscono ora, insieme ad altre componenti concettuali (la mitologia, il tempo, il simbolo, il sistema segnico, etc.), il supporto su cui si fonda la personale ricerca estetica di Barba. L’installazione ha sostituito in un certo senso l’assolutezza formale della scultura, per attivare una più complessa area visiva e una metafisica dell’oggetto, dove il dato della pittura, cioè il colore entra in naturale simbiosi con il dato plastico delle forme, con la loro diversità e molteplicità di intenti. Etnologia e archeologia divengono cosi, per la loro parte, fonte di elaborazione e di immaginazione creativa suffragata al tempo stesso da altri elementi allegorici ottenuti dagli assetti oggettuali e dalle motivazioni teoriche di cui le stesse installazioni si compongono.
Cosi, manufatti della cultura materiale agropastorale e della utensileria contadina: reperti archeologici territoriali simulati e appartenuti alIa civiltà minoica del VII e V secolo a.C. e a quella greca: opportunamente stornati dai loro significati originali, subiscono uno scivolamento di senso e uno stravolgimento di ruoli funzionali all’operazione artistica messa in atto da Barba. Gli stessi strumenti, sottratti in tal modo alIa loro appartenenza culturale di un tempo, si prestano ora ad essere considerati da un diverso punto di vista, con mutate ricettività percettive e di codici, giacche – muovendo proprio dall’etnologia non i manufatti in quanto tali sono culturali, ma e culturale il rapporto fra essi e colui che li usa: in questo caso l’artista che modifica il modello di significazione dei manufatti stessi. Tale eco-ergosistema dl riferimento, unitamente ai reperti simulati del sottosuolo (natura e cultura), presi in prestito da Barba, divengono percorsi artistici validamente integrati da altre componenti, quali la tauromachia simbolica, le capanne fittili di Polizzello, le teorie del campo, la geometria euclidea e le sue proiezioni, l’emblema della maternità e dell’uccello e cosi via. Tutti elementi chiamati a connotare una contestualità creativa coniugata con gli esiti di una poetica dalla straordinaria suggestione plastico-visiva.
Cosi, il collare del campanaccio per le mucche, con la sua architettonica arcata, forma la struttura nella quale è inscritta una linea rossa orizzontale: mentre il setaccio circolare (il “crlvo”) per la pulitura del frumento, sorretto dalle aste del treppiedi dalla cui estremità oscilla, in direzione verticale e laterale, il Pendolo di Foucault volto a sperimentare il moto di rotazione della terra: le cupole di legno che venivano collocate suI braciere e sotto il vuoto delle coperte per riscaldare il letto, nonché altri materiali di analoga fattura manuale, oltre a rappresentare la testimonianza di una memoria verticale solo pretestuosamente referenziale.assumono una loro direzionalità orizzontale concettualizzata dallo stesso Barba attraverso il ruolo simbolico o metaforlco della loro testualità linguistica. Cosi il triangolo rosso inscritto nel cerchio verde e dentro la molla a spirale. Questa creatività tecnica, fabbrile e mentale insieme, in cui il dato “pittorico” e reso da un uso coerente di gialli, di blu d’oltremare, di rossi, di verdi, nonché di terre magre ed opache, riscattano il territorio “amorfo” del luogo e quello di una ricorrente generalizzazione dell’arte, per consentire tra l’altro a questo geniale artista, di superare la concezione rosenbergiana relativa alIa “tradizione del nuovo”, per perseguire invece una stupefacente invenzione della tradizione di cui parlano Eric Hobsbawn e Terence Rangere, e della quale Calogero Barba fornisce in questa occasione al dibattito artistico-culturale in corso, una dimostrazione tra le più intelligenti ed incisive.
Palermo, Dicembre 1991 FRANCESCO CARBONE
Centro Studi, Ricerca e Documentazione “Godranopoli”
NEI TEATRI DELLA MEMORIA
“L’occhio veramente non è fatto per compiere inventari, alla maniera di un perito, o per flirtare, come un maniaco, con le proprie illusioni e con false cognizioni. E’ fatto per organizzare una connessione, un filo conduttore fra le più svariate cose.Un filo conduttore cosi estremamente duttile ci dà la possibilità di comprendere i rapporti che, senza soluzione di continuità,uniscono innumerevoli strutture fisiche e mentali”. (Breton)Questa dichiarazione di Breton mette immediatamente a nudo la trasformazione del processo creativo, avvenuto con l’avanguardia storica che ha privilegiato il momento di elaborazione concettuale dell’opera. L’artista non ricerca più nella natura la fonte dell’ispirazione, ma assume il Linguaggio come unica realtà di partenze. Ed è sul crinale di questa differente complessità in cui concorrono elementi fantastici e riprese linguistiche che viene a collocarsi la ricerca di Barba. Già a partire dalla prima metà degli anni novanta l’artista si mostra incline, negli oggetti-sculture e in articolate strutture ambientali e mi riferisco qui ad opere come Capanna fittile (1992), Sidduni magico (1992), Il talamo di Eva (1993) a ricontestualizzare elementi oggettuali, recuperati dai depositi di remote civiltà mediterranee, carichi di sensi antropici e riferimenti etnologici. Ma anzichè essere assunto nella sua assolutezza materiale per offrirsi ad una contemplazione immobile, come pure accadeva nei recuperi materiali di certa tradizione poverista, “ l’oggetto è cercato per essere tradito anzi, nel repertorio della memoria collettiva, l’artista cerca oggetti da tradire. E il tradimento, il recupero della distanza favorisce uno spostamento di senso sul doppio binario del gioco e dell’ironia”.(Spena) Questa pratica della citazione (e del gioco) non significa però volontà di dissacrazione, bensì esprime l’esigenza di affidare all’opera una costanza storica e un retroterra che dà al momento creativo una maggiore stratificazione. L’artista accetta di non contemplare più la natura per entrare in un rapporto dialettico con la storia e le culture e l’elemento mentale diventa deterrente del processo creativo. Ma è Barba stesso a chiarire la natura di tale processo quando sostiene che “ recuperare l’oggetto serve a capirlo e a cercare di sistemarlo in uno “spazio mentale”, connotandolo di una nuova energia/immagine, consapevole di compiere un’operazione di trasgressione/ avanzamento”, alla ricerca di nuovi rapporti e nella definizione ed eliminazione di altri; per aprire nuove vie di comunicazione”.
L’approdo di un simile atteggiamento sarà poi, in opere come La concretezza del dilemma (1994), Papadoro (1994), Cercar cavilli (1997), Viaggio equilibrato (1998),
nell’esigenza di lasciar parlare la libertà della materia, le sue associazioni con la dimensione del tempo, misura che scandisce il ritmo delle cose; nell’utilizzo morbido dei materiali per lasciarli poi sviluppare secondo attitudini naturali o automatiche. Quella tensione cleptomane ed onnivora che caratterizza la ricerca di Barba si mostra ora ancor più incline alla mobilità, all’interferenza, alla capacità di ibridare o correlare specifici linguistici differenti; accanto al gesto, inteso come pratica del prelievo, che finisce e nomina l’immagine, si accampa la parola; l’estrinsecazione, spesso ludica ed ironica, di un elemento narrativo-letterario. Il “racconto per immagini”, quel racconto che l’arte non può esprimere attraverso viete figurazioni naturalistiche,viene ora riproposto attraverso elementi traslati dove l’ambiguità iconica-l’ambiguità dell’immagine-si accompagna ad un’ambiguità semantica, ad un’ambiguità dei “significati concettuali” espressi dalle parole, per deflagrare poi nel paradosso, nei giochi di parole, nei puns linguistici. L’oggetto finisce cosi per valere non tanto per le sue caratteristiche formali e per sua efficacia simbolica (d’una situazione,d’un consumo), quanto per una sorta di “elevazione a potenza” che ne evidenzia una capacità di trasfigurazione metaforica, metonimica, sineddocica. Come in un viaggio onirico, segni archetipi, frantumi d’archeologie, tracce, brandelli di scritture riemergono dalle ceneri del tempo per riaffiorare nello spazio ugualmente reale ed illusorio dell’opera; in una sorta di extraterritorialità nella quale sacro e profano, natura e cultura, si urtano e si ibridano. E sono teatri della memoria, che nel tempo mitico evocato da Barba trasformano l’ethos popolare e folcloristico, e le sue segrete, estenuate, capacità fascinatorie ed affabulanti, in una sorta di rituale, nel momento magico in cui l’arte si pone come misura aurea del proprio evento. Un evento tessuto nel linguaggio, giocato sui rimandi simbolici ad un immaginario che percorre in velocità la materia e la forma per depositarsi infine davanti allo spettatore. Un tentativo estremo di radicamento nella storia ed allo stesso tempo una presa di distanza da quello splendente vuoto tecnologico che si va profilando all’orizzonte delle nuove culture della globalizzazione.
Roma, 1998 FRANCO BONFIGLIO
“ALCUNE DIVAGAZIONI SU CALOGERO BARBA”
Calogero è troppo giovane per portare quel nome, certamente augurale, ma assai in anticipo sui tempi. Si diceva “calogero” (Kaλòyηpoς) dei monaci bizantini per descriverli o gratificarli, forse, di una “bella vecchiaia”. Ma si potrebbe leggerlo anche come “chi maneggia o fa belle cose antiche”. Nel qual caso sarebbe più appropriato un appellativo così apotropaico per un artista che, senza vantare evidenti “scaramanzie”, pare tuttavia costruire oggetti e simbologie direi antropologici, ma di quel tipo di scienza dall’uomo che ha a che fare piuttosto con la filosofia che con l’antropologia culturale. Sì, perché “il nuovo umanesimo — come scrive Remo Cantoni — non crede più che le forme simboliche della società e della cultura corrispondano al tramonto dell’homo naturalis “. E questo uomo naturale che è in noi e che sopravvive alla civiltà tecnologica in atto, anche indipendentemente dai suoi conati intellettuali, non è separato dal suo passato, dal suo essere stato, insomma dalle sue origini ancorché rimosse. Ed ecco una lunga vicissitudine estetica, vissuta da molti artisti, motivarsi sul rapporto, sempre differito ma sempre postulato, tra la natura e tutto ciò che la trascende. Ricordo una lunghissima discussione tenuta con il compianto Claudio Costa, che sosteneva essere la sua ricerca ispirata ad una sorta di antropologia “mista”, fatta cioè di oggetti inventati nella duplice accezione di “trovati” e “immaginati”. Reperti i primi, artifici i secondi. In ogni caso, il bisticcio ontologico, ancorché irritale, si compensava in una nuova “sintassi”. Il succo del discorso, in altre parole, era questo: dal punto di vista artistico non c’era differenza se non quella di alludere o meno a una qualche amnesia culturale senza tuttavia pretese documentarie, bensì con l’incanto del suscitare in maniera suggestiva tutto un patrimonio antropico che oggi pare disperso nelle pieghe della storia o — che è lo stesso — nei musei della cosiddetta “cultura materiale”, oppure nei più impensabili siti (deserti, stagni, boschi, caverne, ruderi, ecc.) che Claudio frugava continuamente alla ricerca di “cose” che recassero in sé i segni (semioticamente gli indici, le tracce), le cicatrici del vissuto. Ma Calogero artificia oggetti per “ricostruire” le radici e l’identità dell’homo faber che persiste in noi. La natura e la storia sono concetti comprensibili solamente entro l’umana esistenza. E l’arte è una téchne, un modo di “fare” e non un’imitazione dell’inesistente, insomma una platonica mimèsi. Con i materiali più disparati (ma tutti rigorosamente “terreni” o, per dirla con categorie estetiche in atto, “poveri”) apparecchia e mette in scena (e infatti il termine “installazione” mi pare più
idoneo a significare piuttosto il rituale che le cose) secondo un’opzione dettata dalla coppia dialettica nostalgia/speranza — o, se vogliamo, la sua equivalenza più laica, memoria/progetto — che evidentemente, come la testa di Giano, guarda, anzi unisce il passato e il futuro per quel tramite che è nientemeno la porta della città. Le opere di Barba hanno della vicenda umana trascorsa (soprattutto quella arcaica, “sfuggita” al controllo di una sicura storiografia, e quindi più misteriosa) una nostalgia iconica, come chi — penso alla generazione dei nostri padri che non hann mai posseduto un album fotografico dei propri avi — debba inevitabilmente cercare in sé somiglianze di progenitori andate perdute insieme alla loro esistenza. Con un processo di perenne simulazione Calogero costruisce, appunto, dei simulacri. Ne fa la spia il titolo di una sua raccolta di opere presentate in un compact disc: “La concezione dell’origine”, dove concezione sta proprio per raffigurazione arbitraria o congettura, per immaginazione, simulacro. E i simulacri, ci ha avvertito fino alla noia Jean Baudrillard, sono più veri delle cose simulate. Avevano ragione gli Iconoclasti (anche se per imporre quella ragione
perfino con la forza ebbero non pochi torti). L’arte, si sa, anche quando vagheggia una certa referenzialità, cioè un “contenuto”, vero o simulato, lo assume come accessorio rispetto alla sua primaria funzione “poetica” di privilegiare la propria forma. Invertendo lo schema, il linguaggio dell’arte è tale quando, nel complesso delle funzioni che realizza, privilegia quella “autoriflessiva”, cioè la propria forma. Ce lo avevano spiegato i Formalisti russi, con alla testa Roman Jakobson.
Calogero, pertanto, guarda nel tempo della memoria e della congettura: perciò, come gli antichi costruttori di simbologie studiati dagli etnologi, usa materiali e tecniche approssimativi, impropri: è un bricoleur. Le sculture, o meglio le installazioni di Calogero Barba attingono a una tecnologia primordiale, a materiali, come dicevo, terreni, naturali o di povero artificio (bricolage , il termine inventato da Claude Lévi-Strauss per indicare il lavoro dei cosiddetti primitivi, significa anche “di poco guadagno”): sabbia, cera, legno, gesso, piombo, cuoio, ferro, chiodi, grano, arance, carta, scope, sali di rame.. . Rammento una decisa presa di posizione di Gillo Dorfles proprio contro il grande etnologo Lévi-Strauss al quale contestava la similitudine tra l’arte e il bricolage. L’artista, diversamente dal bricoleur, che non dispone di tecnologie alternative, rende propria e adeguata qualunque tecnologia voglia assumere per la realizzazione di un’opera. La differenza del modus operandi — riassumo con parole mie — consiste tra la condizione cogente del bricoleur e la libera opzione dell’artista. Ma torniamo a Calogero Barba. Trovati o no i propri oggetti, dicevo, Calogero li costruisce, anzi compie un atto di possesso; se ne appropria modellandone alcuni, cooptandone altri con un discreto, ma costitutivo controcanto cromatico: le tracce dell’usura (termine che contiene in sé il tempo dell’uso) qui sono rare: la ruggine e gli ossidi dei metalli e dei legni, forse, o i sedimenti nelle sabbie… Ma è il pigmento che, specialmente nelle opere più recenti, appare il meno naturale possibile, come il bleu, il rosso, l’oro. Non c’è scampo, se la distanza tra il “croma” e la “physis” è infinita, vuoi dire che le materie del rito hanno i caratteri del simbolico. Ma caratteri starei per dire allegorici. Il bleu di Calogero è quello del Blaue Reiter che per Wassili Kandinsky significava l’assoluto “spirituale”? Oppure è il bleu di Yves Klein, immagine immateriale dell’universo? O quello irrelato di Mondrian? Di Kandinsky si era perfino detto che nella sua “astrazione” c’erano persistenze naturalistiche nella relazione che inevitabilmente si realizza tra il colore e le forme. Ma in Calogero non ci sono determinazioni cromatiche esclusive. I colori, cioè, possono essere evocativi, avere il doppio codice della cosa e della sua simulazione, oppure avere una pura “astanza”. Ma la struttura, ovvero il complesso di tutto ciò che si manifesta nella fattura di un’opera (la sua forma) appare regolato da una legge, ora geometrica, ora mimetica, in entrambi i casi simmetrica, che del resto corrisponde (cfr. certe strutture simboliche studiate da Carl Gustav Jung e dai suoi allievi in “L‘uomo e i suoi simboli “) all’apparenza dei rito, ad esempio, alla postura dei celebranti, oppure ai modelli culturali di una certa cultura:il cerchio, simbolo magico per eccellenza, la più corale (sociale) disposizione degli attanti; ma anche il triangolo (che Kandinsky considerava “mistico”), per non dire del quadrato (una “divinità” per Pitagora), o di altre complesse morfologie (la spirale, il labirinto, i “mandala” indù, ecc.). Calogero, insomma, struttura gli oggetti come un artigiano, o li ricicla come un rigattiere. Ma non si avverte mai nel suo lavoro il sottofondo dissacrante e ludico del ready made duchampiano, né dell’assemblage dada. Anzi Calogero tenta il miracolo di una transustanziazione virtuale, capace di “fare di un albero un’idea e di un’idea un albero” (Jean Dubuffet). Per esempio, quei trabiccoli, come diciamo noi toscani di quegli ordigni di liste di legno a forma di cupola su cui si
appendeva il veggio (lo scaldino) per riscaldare il letto o per asciugare i panni, non a caso sono definiti “strutture magiche”, anche se non è difficile per omologia riferirli a un emisfero terrestre e quindi accrescerne la fascinazione simbolica; si veda anche l’installazione “Dedicato agli artisti”, composta da arance disposte in cerchi concentrici e trafitte, nel cerchio esterno, da grossi chiodi, che rammenta quelle pratiche iettatorie, dette anche “fatture” di maghe e fattucchiere, pratiche ormai “consacrate dall’uso” epperciò antropologicamente vere (verificabili cioè solamente entro un particolare “universo di discorso”. Non concordo però con qualche esegeta che stringe Calogero troppo da vicino a una supposta eredità o influenza della sua terra nissena. Ma può essere una mia probabile miopia. Tutte queste mie divagazioni fanno parte dell’ermeneutica, di un mio approccio interpretativo, amichevolmente sollecitato, all’opera di Barba, ma non intendono fornire nessuna garanzia, come dire?, estetica. Che cosa fa di tutto questo un’arte? Il grande Nietzsche diceva che l’arte non si spiega. Non è, dico a modo mio, un distributore di significati o di emozioni, me semmai un catalizzatore. L’interprete ha tutto il diritto, anzi la responsabilità di conferire senso all’opera d’arte, come del resto è sempre stato nei secoli dei secoli. Anche Paul Valéry, in perfetta sintonia, diceva che dava alle proprie poesie il significato che davano loro i suoi interpreti. Forse, con l’aiuto “iconologico” di Ervin Panofsky, potremmo identificare il lavoro artistico in quell’insieme di idee, di tecniche e di materie che “violano” le norme e le convenzioni più o meno consuete, prefigurandone continuamente delle nuove, in vista di un tèlos, di una finalità -mi si perdoni l’ossimoro — “inutile” ma necessaria. Inutile, diceva il filosofo tedesco che ho citato sopra, perché non si inserisce nell’etica della civiltà dei consumi, ma necessaria a riqualificare l’esistenza umana. Dunque una finalità per così dire trascendentale, cioè kantianamente “sublime”. Nei confronti di quella vicenda umana che l’antropologia ci ha magnificamente descritto legata strettamente alla terra, chissà mai quando sia nata questa immensa avventura estetica che le ha dato le ali per sollevarla molto più in alto di tutte le altre umane consuetudini.
Firenze, 2001 EUGENIO MICCINI
“Trent’anni con Calogero Barba”
Avevo finito di scrivere alcuni concetti su una mostra ed ero alla ricerca di una frase che potesse mitigare l’asprezza dello scritto quando il telefono, squillando, mi distolse completamente dallo stato di coma vigile in cui ero piombato riflettendo sulla mostra di cui avevo finito di scrivere. Era Calogero Barba che mi chiedeva se avevo ricevuto il catalogo della sua mostra “antologica” di Palazzo Sgadari di Mussomeli. Era arrivato in mattinata e, per la verità, lo avevo sfogliato senza soffermarmi particolarmente né sulle immagini ne tampoco sugli scritti. Ma la telefonata ha acceso il desiderio di capire meglio i contenuti di quel catalogo e, soprattutto, cosa può essere stato per Calogero fare una mostra di quel tipo nel suo paese natale dopo l’avventura di Dorsoduro “Camera 312” promemoria per Pierre – omaggio al critico d’arte Pierre Restany. Infatti esporre sia pure ad un evento collaterale promosso dalla Biennale di Venezia assieme a Franco Spena, Giuseppina Riggi e Lillo Giuliana è stato un momento eccezionale per la vita dell’artista. Evento – del quale la stampa nazionale e internazionale hanno parlato con dovizia di particolari – che lo ha proiettato verso quell’olimpo effimero che è il mondo dell’arte. Una parentesi che, se non è accompagnata da tante e frequenti parentesi, rischia (come avviene sovente nello spettacolo) di farlo ritornare spettatore prima ancora di avere capito di essere attore. Barba queste cose le sa. Spesso ne abbiamo parlato, ci siamo anche scontrati dialetticamente sul problema cercando, ognuno per proprio conto, di affermare le proprie ragioni, sostenendo il principio secondo cui l’uomo fa quel che può limitatamente ai mezzi che ha a disposizione e non, invece, quello che potrebbe fare. Le risorse per mettere in atto progetti di grande respiro culturale spesso vengono fornite a chi non ha risorse umane, culturali, organizzative e intellettuali. Ma questo è un altro discorso.
Le pagine del suo catalogo mi scorrono tra le dita e, in modo sorprendente, mostrano immagini di un Barba anche scultore e pittore, una qualità mai urlata ma che certamente ha. Di fatto l’artista ha preferito sempre la strada della sperimentazione e della ricerca. La frequentazione di maestri come Francesco Carbone ed Eugenio Miccini – vere pietre miliari, nell’ambito antropologico il primo, della parola e delle poesia visiva il secondo – hanno fatto sì che l’artista uscisse allo scoperto esponendo il frutto della sua ricerca. Sacelli sicani, strutture magiche, libri d’artista, utensileria contadina e domestica hanno sostituito la creta. Gli oggetti vengono decontestualizzati e immessi in nuovi spazi-contenitori, la disposizione che ne dà l’artista è il nuovo punto di partenza, sempre diverso ogni volta che lo scultore ne fa oggetto della propria attenzione. Vale la pena sottolineare che l’amicizia e i contatti con il critico d’arte, letterato e artista Franco Spena ha fatto sì che nell’ambito della provincia di Caltanissetta nascesse un vero gruppo di lavoro, formato oltre che da Barba e Spena anche da: Salvatore Salamone, Agostino Tulumello, Giuseppina Riggi, Lillo Giuliana e Michele Lambo, definito dagli addetti ai lavori “Scuola di Caltanissetta”. Il testo presente in catalogo di Ignazio Apolloni – raffinato scrittore – il quale traccia un profilo inedito e incisivo di un Barba ancora giovane ma già tenace e consapevole dei suoi mezzi. Diversamente i testi di Francesco Carbone e Franco Spena, rispettivamente del 1991 e del 1993, entrano nello specifico di Barba ricercatore e indagatore della civiltà contadina. Scrive Spena nel suo testo: “(…) La ricerca si riassume in quel rapporto uomo/tempo/ambiente/territorio entro cui l’artista avvia il suo processo dell’invenire. (…)”. Sensoriale e percettivo è il testo di Diego Gulizia del 2000, mentre Massimo Bignardi pone l’accento sull’aspetto progettuale e simbolistico con ampi riferimenti anche alla pittura. Illuminante per capire le diversità tra arte povera e arte antropologica è il testo presente di Carmelo Strano. Calogero Barba, infatti, non ricicla gli oggetti ma i concetti e lo fa prendendo a “prestito” gli oggetti dada. Altri testi in catalogo sono di: Emilia Valenza, Aldo Gerbino, Franco Bonfiglio, Giovanna Riu, Maria Vinella, Paolo Balmas, Luigi Cocevari-Cussar, Luigi Schifano ed Elisa Ladduca (presidente dell’Associazione Culturale Filati Pregiati) che ha patrocinato la mostra. Una ricostruzione storico-artistica del percorso di Calogero Barba è presente in catalogo ad opera di Giuseppina Riggi. Una pubblicazione tascabile, articolata e illuminante quanto basta, sul lavoro di trent’anni di Calogero Barba.
FRANCESCO M. SCORSONE, “Trent’anni con Calogero Barba”, Centonove, anno XV, N. 37 Messina, Venerdì 21 Settembre 2007.
Dedalos e kokalos
In epoca di multiculturalismo e di transcultura, di scontri-conflittualità-intolleranza tra etnie, linguaggi, tradizionali, culture, stremante attuale appare il lavoro di Calogero Barba, che impone alcune riflessioni sulle interazioni fra centro e periferie, cultura alta e cultura bassa, innovazione e tradizione. L’uomo contemporaneo sembra aver recuperato la nozione di nomadismo, quale risorsa autentica per un immaginario migrante, erratico territorio fatto di differenze e diversità; è nella fusione di cultura-idee-immagini-linguaggi, che oggi si offrono nuove utopie, si inventano nuovi valori, si originano nuove visioni. In tale territorio mentale, nell’avvicendamento di natura e cultura, si situa l’opera di Barba. L’Artista traccia itinerari formali-concettuali dalle forti valenze antropologiche, allusive alla ritualità del magico, del primario, dell’arcaico. Tutta la sua ricerca si orienta verso l’emergenza di materiale archetipo affiorante dai manufatti della cultura contadina e dalle tracce delle testimonianze storiche mediterranee e meridionali. Nel segno di una creatività ludica, calda ed espansiva, flessibile e molteplice, in grado di coniugare con ironia le categorie del tempo, del mito, del simbolo, si attiva un complesso gioco di rimandi e scambi linguistici; negli oggetti-scultura, nelle installazioni, nelle situazioni ambientali, barba mette in atto una fervida espressività febbrile e mentale che fonde colorazioni accese, essenzialità minimale, strutture geometrizzanti, forme archetipe.
Come in “Sacello sicano” o in “Ovum pictum” in “Impronte pedestri”o in “Vettore virtuale”, sino a “Papadoro” o a “Op-op-op…”, e agli ultimissimi lavori, dove tutto è giocato sul piano dell’azione-evento-rito, nella consapevole coscienza di compiere “un ‘azione di trasgressione-avanzamento”, come l’autore afferma, nell’operazione di eliminazione, definizione e sostituzione di rapporti espressivi. Nello spazio vitale dell’opera, segni-oggetti-cromie-scritture sono organizzate secondo i codici della plurisensorialità percettiva che vede all’azzurità del solfato di rame unirsi la porosità della carta e la rugosità del legno, alle qualità alchemiche del ferro sommarsi l’odore resinoso delle cere ma anche il calore, le forme e i profumi dei reperti naturali.
“Recuperare e simulare reperti, esibire strutture oggettuali per comunicare… Per riconquistare quella dimensione del quotidiano ormai smarrita e deviata dalla civiltà ipertecnologica e cibernetica”, queste – come suggerisce lo stesso artista – le finalità operative di Barba che nella ricostruzione di nuovi spazi mentali conduce la sua personale ricerca di diverse modalità espressive, linguistiche e comunicative.
1997 Roma (dal Depliant della mostra personale “Dedalos e Kokalos”)
Maria Vinella
L’arte concettuale della memoria
E’ davvero strabiliante come l’arte di Calogero Barba consista nella manipolazione, trasfusione e trasformazione delle vestigia della civiltà contadina in quelle della postmodernità. Questa l’essenza della sua ricerca. Memorie ricordi, simboli feticci, immagini e oggetti materiali di un mondo scomparso che rivivono al presente nelle forme scultoree e pittoriche dell’astrattismo.
Chi ha vissuto quell’epoca, la nostalgia di un eldorado di semplicità e fatica, si ritrova spiazzato e spaesato, non riconosce e non si riconosce nel vissuto antropologico ricreato dalle opere del Barba. Questa la sensazione momentanea che si prova e subito dopo la rivelazione magica, l’istinto e la cultura di una rivisitazione che piace e trova approvazione, compiacimento, convinto consenso.
Lo stupore segue la provocazione di una invenzione, tra soggetti e concetti, per dirla con il titolo della sua ultima personale a Mussomeli, un impianto di colori e forme lontane e poco familiari dietro cui si nasconde l’arcano e irresistibile moto dell’anima, l’anima della civiltà contadina che si veste di postmodernità. Un volo pindarico, una strozzatura della storia, una profanazione della memoria che ridesta emozioni, passioni, pensieri. E si che è difficile l’arte concettuale che si nutre di un passato trasecolato, trapassato, irrimediabilmente scomparso. Ferito e tramortito il fruitore che alle sue opere si accosta perplesso e incredulo, quasi diffidente e contrariato. Perché gli oggetti, le immagini e i ricordi non sono più quelli. Sono il patrimonio conservato nelle nuove forme del linguaggio scelto da Barba per raccontare quel mondo, quella ricchezza di sensazioni e sentimenti che nessuna arte postmoderna potrà cancellare utilizzando gli stessi strumenti dell’innovazione.
Questo il merito indiscusso delle sue opere.
Non importa se i messaggi e i codici di lettura vengono riconosciuti dal visitatore per un viaggio nel tempo che non rende giustizia alla sua memoria, che lo inganna per trame e racconti che assumono forme e linguaggi non facilmente comprensibili. L’arte si nutre di immagini, ricordi e concetti e nella sua parusia creante si mostra per quello ché è e vuole essere: viaggio nostalgico nel passato, saudade di una infanzia povera ma felice, engagè politique che trasuda dalle opere e si fa coscienza culturale. Tout court, terreno di espressione di una semantica figurativa che non cede allo strumento stilistico delle forme ma che anzi palesa contenuti e idealità forti e originali.
Tonino Calà, da La Sicilia, “L’artista di Mussomeli”, Catania, Mercoledì 3 Ottobre 2007.
VISIONI IN BLU E GIALLO PER L’ARTISTA
SICILIANO CALOGERO BARBA
Calogero Barba è un artista “visionario” la cui sorprendente produzione appare sospesa fra fantasioso sperimentalismo e recupero di spunti iconografici più tradizionali.
Evocativamente (e significativamente) diviso in due sale – gialla e blu, in base al colore dominante nelle opere esposte – l’allestimento realizzato alla galleria Studio 71 riflette fedelmente le doti immaginifiche di questo giovane autore siciliano.
Giallo e Blu, un dualismo cromatico che sembra alludere ad una interiore psicologica polarità, alla contrapposizione fra malinconia ed euforia, fra lunare intimistico e vitalità solare. Ma anche espediente tecnico-stilistico che consente ai vari soggetti sovrapposti alle superfici monocrome di risaltare in tutta la loro totemica e ieratica individualità. Cosi in Dedalo ed Icaro, la tragica ed utopistica aspirazione alla fuga dal labirinto (mentale) trova una simbolica e tautologica rappresentazione in sei piccole ali di cera blu simmetricamente allineate in due pannelli lignei di analogo colore.
Altrove è l’idea del viaggio a prendere corpo- di un itinerario al contempo artistico esistenziale sotto forma di corteo di minute tartarughe (sempre di cera, rivedendo la tradizione ceroplastica insulare) il cui percorso, azzurro e semicircolare, si snoda lungo tre pannelli blu profondo sovrastati da una fredda numerazione digitale. Un linguaggio fatto di geometrie e simmetrie, ma nella cui griglia razionale trova felice collocazione tutto un mondo di fantasie, idee e pulsazioni, in un riuscito equilibrio formale che tempera tensioni, contrapposte. Nell’esemplare Sguardo frontale dieci tartarughe si fronteggiano a coppie su una superficie gialla e scabra, delimitando le parole “sguardo” e “frontale” (quest’ultima invertita e leggibile, leonardescamente, allo specchio) in un gioco di spinte e controspinte, di rovesciamenti percettivi e cognitivi, che conferiscono emblematicamente forma ad un magmatico vissuto interiore.
IL Mediterraneo, Palermo, 13 Giugno 2000 Salvo Ferlito
IL QAL – AT
Non ho mai scritto nulla su Calogero Barba, in barba a quanti se lo sarebbero aspettato. Per la verità non ho neanche scritto di tanta altra gente, ma perché non me l’hanno chiesto. Voglio rimediare. Voglio promuovere una campagna pubblicitaria a favore di questo instancabile artista. E dico instancabile perché la sua ricerca non ha soste.
L’ho conosciuto che aveva i capelli lunghi e i pantaloncini corti. Eravamo al mare, in quel di Tusa. Vi si davano concerti (nel senso che si concertava come fare uscire dall’anonimato un pezzo di storia dell’arte). Il sito era buono. I Nebrodi sufficientemente aridi e pietrosi. L’intento era quello di lanciare in alto un Consagra e consagrarlo come il più geniale degli inventori di stelle a sei punte (per non dispiacere quelli a cinque punte). Fatto uno scandaglio non ci fu il più piccolo dubbio. Non il sagrato di una chiesa, non un torrente di parole ma un vero e proprio corso d’acqua avrebbe ospitato la scultura. Si fecero indagini idrogeologiche e persino il più classico dei carotaggi. Saputo con certezza che su quel greto ci si sarebbe potuto poggiare il manufatto (senza tema di smentita) si chiamarono i fabbri; i carpentieri; i chiodaroli (fatti venire espressamente da Firenze, da via dei Chiodaroli: o forse sono a Roma?) e le altre maestranze. L’incarico di dirigere i lavori fu dato al Barba. Che da allora s’è fatto crescere la barba un po’ per confondere le idee a chi non riesce nemmeno ad averne, e un po’ per partito preso.
Che inaugurazione, quel fatidico giorno! Che inaugurazione e che canti di giubilo da parte di chi non aveva potuto prendere parte all’impresa. Ben fatte le lamiere piene di volute; riusciti i contrasti tra il grigio e il nero della scultura. Se ancora ci penso mi vengono i brividi nel vedere i due abbracciarsi, e posare l’usbergo del maestro sulle spalle del discepolo. Costui (dico il Barba) non finiva di dire quanto si sentisse gratificato dell’onore ricevuto di potere fare da discepolo a un maestro, e che maestro! Per dare un segno tangibile di ciò che gliene veniva avrebbe deciso lì per lì (e infatti decise lì per lì) di abbandonare la ricerca del tempo perduto e cercare in sua vece moduli espressivi di tutto rilievo: come l’uso del papavero per farne tabacco da naso.
Fu, quello, un fatto rivoluzionario. Trattare i pigmenti, farne macchie di inchiostro (lei fa tosto, e sapete il monello che ha risposto?), diluire sulla carta fatta a mano progetti sapidi di sapienza non era stato da tutti. Se ne accorse – primo fra tutti – il solito Francesco Carbone. Il quale scrisse di lui che, partendo dall’etnografia stava approdando, anzi meglio debordando verso una estetica forte di una teoria tra le più originali e avanzate. E aggiunse quindi – in occasione di Lumina/Limina – che oggi si poteva parlare più compiutamente di lui come di un plastico né dadaista né pop; di un architetto polisemico lontano mille miglia dall’Arte povera.
Ma se povera non è l’arte del Barba di quanto è più ricca la sua voglia di fare, di distinguersi e prendere le distanze dal suo già detto maestro? “Io sono la tua guida e il tuo autore” – gli aveva detto quel divino ed a lui avevano fatto eco Antonio Presti e Ludovico Corrao.
Correva l’anno mille (il resto non conta, o se si preferisce il resto va da sé). Di strada ce n’era da fare… I libri erano lì ad attendere che qualcuno li leggesse ma non era più chi lo volesse. Se erano intonsi la maggior parte di essi? certo che sì! E allora cosa se ne fa un artista dei libri, se non prenderne la forma e dar loro nuova forma? Che forse essi son fatti solo per essere letti?
Qui si aprì una diatriba tra chi pensava che il libro potesse essere un’opera d’arte e chi invece pensava esattamente il contrario. Vinse la reticenza in alcuni; in altri prevalse la cupidigia. Finalmente il dilemma fu risolto: si decise per l’essere (il to be) e si scartò il non essere (il not to be) Oggi per essere in linea con i tempi e se si vuole davvero amare la pagina scritta non si può far finta di niente ma fare (e disfare) sempre più libri. L’ho visto intento – il Barba – a farne uno grande quanto una torre. Un po’ tutti adesso si aspettano che ci metta i merli. A quel punto non si potrà non rimanere ammirati da tanta audacia. Specialmente se per esporla sceglierà quel posto assolutamente sincopato meglio noto nel centro della Sicilia come il Qal-at. Qal come Caltanissetta, ma anche come avventura nello spazio.
Ignazio Apolloni